Viale delle Cascine 152/F, 56122 Pisa – Italia
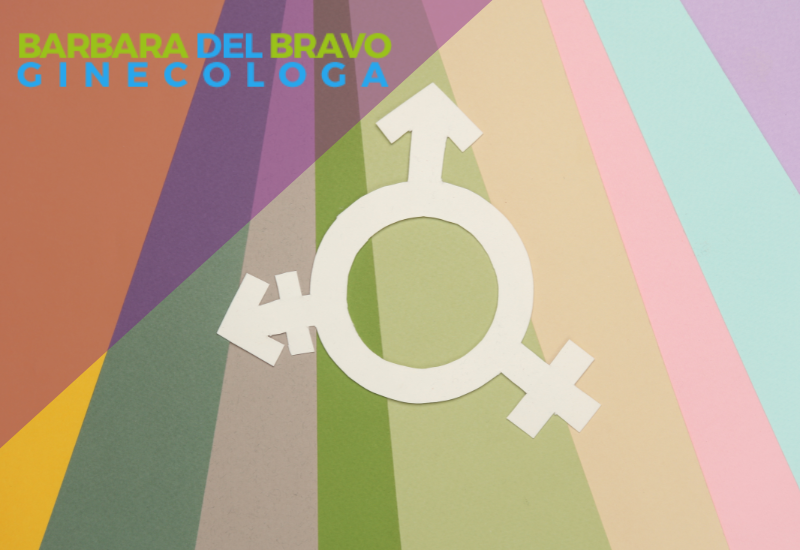
Percorsi di Genere: Comprensione e supporto medico per l'affermazione di sé
Di |0 commenti
In medicina, il concetto di genere si sta ampliando enormemente, per andare oltre le tradizionali definizioni binarie di maschio e femmina. Tuttavia, il percorso per un riconoscimento pieno e consapevole delle identità di genere è tutt’altro che lineare. Come ginecologa, mi rendo conto di quanto sia complesso e sfaccettato l’universo del genere e di quanto sia importante affrontarlo con sensibilità e competenza. Dietro ogni paziente ci sono storie di autodeterminazione, ricerca di sé e, talvolta, di sofferenza.
Parlare di genere significa muoversi in un campo vasto e complesso, in cui concetti come identità di genere, sesso biologico e orientamento sessuale si intrecciano, ma non sono mai del tutto sovrapponibili. Riconoscere questa complessità è il primo passo per offrire un supporto autentico e informato, specialmente da parte di noi medici. Comprendere appieno questi concetti richiede un ascolto attento e una prospettiva che vada oltre le semplificazioni. Ed è da questo punto che vorrei partire.
Il superamento della concezione binaria dei sessi
La terminologia e i concetti legati alle questioni di genere sono in costante evoluzione. Comprendere appieno le diverse sfumature può essere complesso, specialmente in una società ancora ampiamente ancorata a una visione binaria del sesso. Tuttavia, oggi sappiamo che il genere è molto più di una semplice classificazione di "maschio" o "femmina". Come spiegato da Zucker e Bradley (1995), il gender spectrum supera il binarismo tradizionale, riconoscendo una gamma di identità di genere che vanno oltre il maschile e il femminile.
La visione binaria dei sessi, che per lungo tempo ha dominato il pensiero medico e sociale, presupponeva che ci fossero solo due modi di essere: uomo o donna, basati esclusivamente su caratteristiche biologiche di cui si è a conoscenza fin dalla nascita, come i cromosomi o gli organi sessuali. Tuttavia, questa concezione non è più adeguata a spiegare la complessità delle esperienze umane. Le identità di genere possono essere molto più fluide e variegate: esistono persone che non si riconoscono completamente in nessuno dei due generi tradizionali, o che si collocano su un continuum che comprende identità non binarie, genderqueer, agender e molte altre. Per fare chiarezza:
- Sesso biologico definisce il sesso assegnato alla nascita. Si riferisce alle caratteristiche fisiche con cui una persona nasce, come cromosomi, ormoni, organi riproduttivi e anatomia. Questi aspetti definiscono in modo tradizionale la categorizzazione maschio/femmina, ma non sempre si allineano con l’identità di genere di una persona.(definisce il sesso assegnato alla nascita)
- Orientamento sessuale si riferisce all’attrazione fisica, romantica o emotiva verso altre persone, che è indipendente dall’identità di genere. Esistono infatti persone con identità di genere diverse che possono avere attrazioni verso lo stesso genere, l'altro genere o più generi.
- Identità di genere descrive il senso interno e personale di appartenere a un genere, che può essere allineato o meno con il sesso assegnato alla nascita. Questa dimensione riguarda come una persona percepisce se stessa e vive, e può variare lungo un continuum di genere, come descritto nel concetto di gender spectrum citato in precedenza. Non si tratta di una semplice definizione, ma di una parte profonda dell'identità individuale, che ognuno esplora e afferma in modi diversi e che deve essere intesa come costrutto non binario che può comprendere un range di differenti identità.
Il termine “non binario” include persone i cui generi sono costituiti da più di un'identità di genere contemporaneamente o in momenti diversi (ad esempio, bigender), che non hanno un'identità di genere o hanno un'identità di genere neutra (ad esempio, agender o neutrois), hanno identità di genere che racchiudono o fondono elementi di altri generi (ad esempio, poligenere, demiboy, demigirl) e/o che hanno un genere che cambia nel tempo (ad esempio, genderfluid) (Kuper et al., 2014; Richards et al., 2016; Richards et al., 2017; Vincent, 2019).
Transgender è il termine utilizzato per descrivere individui la cui identità e l'espressione di genere non corrispondono al sesso assegnato alla nascita. Le persone transgender possono essere maschi (persone assegnate al sesso femminile alla nascita, ma che identificano il loro genere come maschio) e femmine (persone assegnate al sesso maschile alla nascita, ma che identificano il loro genere come femminile); (Connolly, Zervos,Barone, Johnson e Joseph, 2016).
Nel mio lavoro, vedo spesso quanto sia importante rispettare l’identità che ognuno sceglie di affermare, senza limitarsi a rigide definizioni, ma ascoltando la realtà individuale.
Assistenza sanitaria transgender - l’iportanza di un approccio multidisciplinare e personalizzato
Negli ultimi decenni, la crescente attenzione della comunità scientifica e medica alle questioni di genere ha portato un cambiamento significativo nell’approccio all’assistenza sanitaria transgender. Se in passato l’accesso ai percorsi di affermazione di genere era spesso ostacolato da criteri rigidi e da una visione patologizzante dell’identità transgender, oggi le linee guida fornite dalla World Professional Association for Transgender Health (WPATH) - organizzazione internazionale dedicata alla promozione della salute delle persone transgender e non binarie fondata nel 1979 - promuovono un modello basato sulla flessibilità e sul rispetto dell’autodeterminazione. Con l’ottava versione degli Standard of Care (SOC-8), il concetto di "transizione" è stato progressivamente sostituito da quello di "affermazione di genere", sottolineando che non si tratta di un passaggio da un genere a un altro, ma di un processo individuale volto a esprimere la propria identità nel modo più autentico. SOC-8, risale al 2022 ed è stata sviluppata sulla base delle migliori evidenze scientifiche e mira a guidare i professionisti sanitari nell’offrire percorsi sicuri ed efficaci per l’affermazione del genere.
Alla base di questo approccio c’è la consapevolezza che non esiste un unico percorso valido per tutte le persone transgender e di genere non conforme. Le necessità variano in base a una serie di fattori clinici, psicologici e sociali, e per questo motivo i percorsi devono essere costruiti su misura per ogni individuo. La presa in carico deve dunque tenere conto della complessità e dell’eterogeneità dei bisogni, adattandosi alle specifiche esigenze della persona e offrendo una gamma di possibilità piuttosto che un modello predefinito.
Tuttavia, affinché questa visione possa tradursi in un sistema di cura efficace e rispettoso, è necessario che l’assistenza sanitaria per le persone transgender sia multidisciplinare. La presa in carico deve coinvolgere diverse figure professionali, tra cui endocrinologi, psicologi, psichiatri, chirurghi plastici, ginecologi, foniatri, assistenti sociali e associazioni di supporto, in un’ottica di dialogo e integrazione. L’obiettivo non è quello di imporre un percorso, ma di accompagnare la persona nella costruzione di un iter che risponda ai suoi desideri e si adatti alle sue necessità. Fondamentale, in questo senso, è il ruolo del supporto psicologico, che però non deve agire come filtro all’accesso ai trattamenti, ma come spazio di informazione e sostegno. Le attuali linee guida ribadiscono con chiarezza che il compito del professionista della salute mentale non è valutare “l'idoneità" della persona al percorso di affermazione di genere, ma fornire strumenti per un processo decisionale consapevole, evitando qualsiasi forma di gatekeeping.
L’importanza dell’evoluzione del linguaggio: da disforia di genere a incongruenza di genere
Un aspetto centrale di questo cambio di visione è l’uso del linguaggio. Il modo in cui si parla di identità di genere non è neutro, ma contribuisce a modellare la percezione sociale e a determinare il grado di inclusione o esclusione delle persone transgender nei contesti di cura. Per questo motivo, è essenziale che gli operatori sanitari si impegnino ad adottare una terminologia rispettosa, utilizzando il nome e i pronomi scelti dalla persona e prestando attenzione al modo in cui descrivono il corpo e l’esperienza di chi si rivolge a loro. Sempre la WPATH sottolinea l’importanza di discutere con il paziente quale linguaggio preferisce, riconoscendo che il rispetto della terminologia non è una semplice questione formale, ma un elemento cruciale nella costruzione di un ambiente di cura sicuro e accogliente.
Fino a poco tempo fa, in ambito medico, per descrivere il disagio vissuto da una persona la cui identità di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita veniva utilizzato il termine "disforia di genere". Tuttavia, con l'introduzione dell'ICD-11 (l’undicesima revisione della Classificazione Internazionale delle malattie) da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2019, il termine è stato sostituito da "incongruenza di genere", segnando un importante spostamento nell'approccio alla questione . Questo cambiamento riflette un passaggio importante dal smettere di considerare la condizione come una patologia mentale alla comprensione di essa come un aspetto legittimo dell'identità personale e della salute sessuale.
L'introduzione del termine "incongruenza di genere" nell'ICD-11 rappresenta, dunque, non solo un'evoluzione terminologica, ma anche una trasformazione più profonda nella comprensione delle questioni di genere. Tale evoluzione ha portato a una visione più inclusiva e rispettosa delle identità non conformi, riconoscendo la diversità come una dimensione fondamentale dell'esperienza umana. In questo contesto, il linguaggio gioca un ruolo cruciale: le parole non sono mai neutre, ma hanno il potere di plasmare e riflettere la realtà sociale e culturale. L'adozione di un linguaggio più preciso e consapevole non solo aiuta a ridurre la stigmatizzazione, ma contribuisce anche a riconoscere e legittimare le esperienze individuali, promuovendo un’ inclusività che afferma e rispetta la pluralità dell'identità umana.
Gli step del percorso di affermazione di genere
Il percorso di affermazione di genere segue diverse tappe, che come abbiamo più volte sottolineato, possono variare a seconda delle necessità individuali. Sulla base delle linee guida WPATH gli step principali della presa in carico dovrebbero essere i seguenti:
- Fase di esplorazione dell’identità e supporto iniziale
- Colloqui clinici con professionisti esperti in identità di genere
- Informazioni sui possibili percorsi di affermazione
- Visite endocrinologiche
- Valutazione delle necessità individuali (sociali, mediche, psicologiche)
- Accompagnamento e supporto psicologico continuativo
- Inizio della terapia ormonale, se desiderata, sotto supervisione endocrinologica (femminilizzante-mascolinizzante/de-femminilizzante o de-mascolinizzante)
- Visite endocrinologiche
- Accompagnamento nel percorso di affermazione, fornendo informazioni ed elaborazione emotiva
- Valutazione clinica e relazioni da parte dell’équipe multidisciplinare
- Interventi chirurgici di affermazione di genere (se richiesti)
- Eventuale richiesta al Tribunale per l’autorizzazione in Italia
- Procedure chirurgiche per l’adeguamento delle caratteristiche fisiche, a seconda delle esigenze della persona
- Rettifica anagrafica e riconoscimento legale
- Procedura legale per la modifica dei documenti in accordo con l’identità di genere affermata
5. Formazione e consapevolezza
La trasformazione dell’assistenza sanitaria transgender non può limitarsi all’introduzione di nuove linee guida, ma deve tradursi in un cambiamento strutturale, sociale e culturale. Questo significa non solo garantire l’accesso ai trattamenti di affermazione di genere, ma anche creare un sistema di cura che riconosca la legittimità delle identità transgender, elimini le barriere all’accesso alle cure e promuova il benessere delle persone in ogni fase del loro percorso. Affinché questo cambiamento possa realizzarsi, è necessario un investimento nella formazione degli operatori sanitari. L’assistenza sanitaria transgender non riguarda solo gli interventi medici, ma anche un cambiamento strutturale all’interno del sistema sanitario per garantire un trattamento equo e rispettoso.
Per concludere, l’elemento essenziale per per migliorare l’assistenza sanitaria transgender e, più in generale, il modo in cui la società comprende le identità di genere, è l’accesso a risorse affidabili e aggiornate. La conoscenza non è solo uno strumento per i professionisti della salute, ma anche un mezzo per chiunque voglia approfondire questi temi con l’obiettivo di ampliare il proprio punto di vista ed empatizzare con esperienze diverse dalla propria.
Infotrans.it, un portale istituzionale nato dalla collaborazione tra l’Istituto Superiore di Sanità e l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Questa piattaforma offre informazioni scientificamente validate e raccoglie buone pratiche per i professionisti del settore socio sanitario, contribuendo a colmare il divario formativo che ancora caratterizza molte realtà cliniche.
Società Italiana Genere, Identità e Salute (SIGIS), un’associazione professionale impegnata nella promozione della salute fisica, mentale e sociale delle persone con non conformità di genere, con l’obiettivo di diffondere conoscenze aggiornate e favorire la formazione di professionisti sanitari.
Ma per comprendere a fondo le esperienze transgender, è fondamentale andare oltre la prospettiva clinica e aprirsi a una conoscenza che sia anche culturale e personale. Letture come "Gender is Over" di Isa Borrelli, che esplora le sfumature dell’identità di genere con un approccio divulgativo e accessibile, o "Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità" di Judith Butler, un testo teorico che ha rivoluzionato il dibattito sul genere e sull’identità, offrono strumenti preziosi per decostruire pregiudizi e comprendere la varietà delle esperienze umane. L’incontro con queste prospettive non è solo un esercizio intellettuale, ma un passo concreto per costruire una società più inclusiva, in cui l’identità di ciascuno venga riconosciuta e rispettata nella sua autenticità.